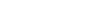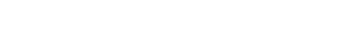Nel nostro paese l’assenza di una volontà politica chiara in tema di assistenza ai malati terminali, un certo grado di impreparazione a vari livelli, hanno fatto sì che per anni il problema Hospice non solo non venisse risolto ma neppure affrontato. Se qualcosa è avvenuto lo si deve ai pionieri, a quelle persone che sono riuscite a realizzare un loro progetto personale, spesso incontrando ostacoli. È il caso dell’Hospice Piccole Figlie di Parma.
Nel nostro paese l’assenza di una volontà politica chiara in tema di assistenza ai malati terminali, un certo grado di impreparazione a vari livelli, hanno fatto sì che per anni il problema Hospice non solo non venisse risolto ma neppure affrontato. Se qualcosa è avvenuto lo si deve ai pionieri, a quelle persone che sono riuscite a realizzare un loro progetto personale, spesso incontrando ostacoli. È il caso dell’Hospice Piccole Figlie di Parma.
Abbiamo incontrato la dott.ssa Anna Ventimiglia, psicologa psicoterapeuta.
1 • La morte del paziente rappresenta l’ultimo atto di un percorso che in qualche modo permette allo psicologo di sperimentare, conoscere con pienezza l’esperienza della vulnerabilità e di confrontarsi con le fantasie e le illusioni su cui ha costruito la propria identità, le proprie scelte come persona e come professionista. Cosa significa per lei lavorare in Hospice?
L’attività in hospice costringe ogni operatore a rapportarsi con l’autenticità delle emozioni uscendo dai manierismi e dalle finzioni emozionali. L’intensificarsi dei sistemi e dei “modi virtuali” che condizionano le nostre esistenze ci sta pericolosamente allontanando dalla saldatura autentica con i nostri pensieri e le nostre azioni. Lavorare in hospice quindi ci porta ad assumere consapevolezza piena che “quei pazienti” siamo noi, creature viventi e tutti appartenenti all’unica Comunità della Terra.
2 • Quali sono le difficoltà con le quali si deve confrontare lo psicologo che opera in una unità di cure palliative?
Sul piano dell’intervento clinico con i pazienti terminali ho dovuto lavorare parecchio per arrivare ad interiorizzare la consapevolezza del “limite temporale” di una mia azione che comunque inizia e termina, sempre, “quel giorno”. Al termine di ogni incontro saluto il paziente con un arrivederci ma so che non è detto che io possa rincontrarlo. Per questo, ogni incontro, rappresenta un’esperienza a sé stante, limitata, dove interiorizzo l’unica dimensione temporale possibile, quella del Presente, dello “Stare”.
3 • Come si sopravvive al confronto con la morte, con il proprio limite?
Tollerando e contenendo la sensazione di impotenza nel non avere risposte sempre esaustive ai misteri della vita e dei rapporti, imparando l’ascolto di se stessi in primis e accogliendo l’”altro” che è “altro da noi ma condivide con noi”. Imparando anche a vivere giorno per giorno, con un atteggiamento di riverenza verso il mistero dell’esistenza.
4 • Che cos’è oggi una “buona morte”?
Significa umanizzare gli interventi di cura. Sembrerebbe quasi un paradosso, il fatto che proprio gli stessi dettami della biotecnologia che prolungano in qualche modo le nostre esistenze e quindi anche un certo senso di onnipotenza, siano gli stessi a dirci che in realtà l’uomo è biologicamente programmato a termine. Umanizzare l’intervento di cura significa contestualizzare nella storia di “quel” paziente i protocolli di presa in carico del paziente stesso: le procedure operative quindi non vanno applicate tout court seguendo linee di universalità, ogni situazione è speciale. Personalmente non ricordo mai il numero della stanza dove è ricoverata la persona, ma non dimentico mai il suo nome, così come un oggetto, o un dettaglio, che ho notato sopra il suo comodino o l’odore o il profumo dominante nella stanza.
5 • Cosa esprime la persona nella malattia?
Esprime la sua assoluta unicità e la morte attesa la rende profondamente umana. Anche dal punto di vista dell’intervento psicologico accade che i pazienti mi chiedano di esporre la mia persona al cuore della loro esperienza di esseri umani. L’atto di cura psicologica dunque è porsi accanto al loro dolore condividendo la disperazione, senza dare alcuna risposta risolutiva.
6 • Cosa avviene nel momento in cui la vita e la morte si toccano?
È come il punto di restringimento di una clessidra: la polvere scende e passa da quel passaggio stretto fino a terminare e poi ridiscende: è la nascita della morte. I sogni e i deliri dei pazienti hanno molto a che vedere con l’idea della “vita dopo la morte” poiché veicolano allusioni simboliche e senz’altro elementi archetipici che non avrebbero accesso alla coscienza per vie razionali. La mia idea è che nel momento in cui il filo della vita sta per raggiungere quello della morte il paziente avverta un richiamo all’origine e il distacco dal terreno.
7 • Il contatto corporeo con il malato, il Nurturing touch, è uno strumento potentissimo per entrare in contatto con l’altro nel momento in cui le parole non servono o non sono più utili…
Il contatto è per sua natura all’origine del senso di sé perché offre il senso del confine; la madre o chi per lei riproduce l’antica parete uterina e il neonato, come il malato terminale, può sperimentare una personale percezione del suo limite solo attraverso ciò che tocca. Il toccare è l’unica modalità che permette sempre una relazione con il paziente, dando a lui/lei la possibilità di continuare a vivere l’esperienza della sensorialità e del sentirsi contenuto, sentirsi vivo.
8 • Che cosa vuol dire affrontare il tema della morte con i bambini?
La tutela della loro naturalità, vitalità, creatività, della loro bellezza, aiutarli a farli riflettere sul modo in cui si rapportano e trattano gli altri bambini, gli animali e le cose. Far capire loro che tutto è collegato e che è possibile sperimentare un senso di condivisione nel prenderci a cuore il benessere futuro delle cose viventi.
9 • Cosa ha significato ricevere il Premio Sant’Ilario, per la vostra équipe?
L’opportunità di vivere secondo un senso di responsabilità universale, identificandoci con l’intera comunità, condividendo nell’ottica dell’interdipendenza, quello spirito di solidarietà umana e di affinità che si rafforza quando viviamo con rispetto, gratitudine e umiltà verso il mistero dell’esistenza. Abbiamo urgente bisogno di una visione condivisa dei valori fondamentali per un modo di vivere che orienti e sostenga le nostre condotte.