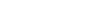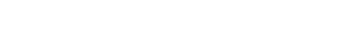Continuiamo la conversazione con la regista Claudia Tosi, la cui svolta professionale è avvenuta nel 2003, quando andò a Bardonecchia ad un workshop sul documentario di creazione e se ne innamorò. Fu lì che vide un curioso documentario sulle rotonde. Un regista tedesco aveva fatto un film che partiva dal seguente quesito: “come mai ci sono così tante rotonde in Europa”? Le sembrò magnifico. Nel tempo Claudia ha realizzato diverse opere tra le quali Private Fragments of Bosnia e Mostar United per poi approdare al suo ultimo film: The Perfect Circle.
• Oggi stai portando The Perfect Circle in Italia e all’estero. Un successo!
Considerato che i distributori italiani si sono rifiutati di distribuire il film, che nessuno avrebbe mai voluto vedere perché “bellissimo…ma troppo triste, Claudia”, 43 proiezioni, fino ad ora, e una media di 92 spettatori per proiezione, mi sembrano un successo. Stiamo pur sempre parlando di un film documentario e non di Blade Runner. Ci sono in programma proiezioni almeno fino a novembre. Accompagnare il film è magnifico. Poterlo proiettare nelle sale cinematografiche permette di conservare il forte impatto sensoriale dell’opera e favorisce l’incontro di professionisti e cittadini, per aiutare le cure palliative ad uscire dai soliti circuiti, quelli di chi le conosce già.A volte ho la sensazione che la visione funzioni come una sorta di rituale collettivo, che include anche un’apertura incredibile, alla fine della proiezione, momento in cui, inaspettatamente, il pubblico inizia a condividere le proprie esperienze. C’è sempre molta commozione. C’è chi si stupisce, con orgoglio, di essere riuscito ad affrontare il dolore di un’esperienza personale, rivissuta nel film; c’è chi lo ha visto più e più volte; chi, alla seconda volta, ha portato la propria madre.
• C’è una comunità che sta crescendo intorno a The Perfect Circle…
Ed io sto incontrando persone splendide e sto imparando tantissimo. Ma soprattutto sto conoscendo un’Italia operosa, gentile, generosa, dignitosa che cozza tantissimo con quella rabbiosa che la televisione e i social media ci propinano. Anche la Sanità che sto incontrando non è certo quella delle “48 ore di attesa in corridoio”.
È una Sanità responsabile, attenta e silenziosa, che non fa scalpore. Sembra di essere in un mondo parallelo. La cosa che mi colpisce di più è che ogni proiezione è stata organizzata dal pubblico. Abbiamo aderito ad una piattaforma di distribuzione dal basso, Movieday, che permette agli spettatori di organizzare gli eventi nelle loro città e nei cinema che preferiscono. Mi sembrava una buona idea per invitare ad una cittadinanza attiva. Ormai abbiamo viaggiato in tredici Regioni, sempre Nord Italia e Centro, mai al Sud. Delle isole, solo la Sardegna.
La televisione italiana si è ben guardata dal selezionare il film, invece la TV Belga l’ha mandato in onda in prima serata, di sabato, e successivamente l’ha replicato.
• Sei stata ad alcuni Festival importanti e, a Parma, abbiamo proiettato il film all’interno de Il Rumore del Lutto.
Sì, siamo stati ad alcuni festival importanti; abbiamo avuto una premiazione che per me ha significato tantissimo, ma ho abbastanza trascurato la circuitazione internazionale festivaliera, perché mi sono voluta concentrare sulla distribuzione italiana, per gli importanti risvolti sociali che ho immaginato sin dall’inizio. Molte Asl stanno impiegando il film per sensibilizzare gli operatori sui temi del fine-vita e dell’umanizzazione delle cure, altre volte organizzano eventi assieme ad hospice o associazioni di volontariato. Si stanno creando sinergie, nuove reti e contaminazioni.
Credo molto nel potenziale politico e sociale del cinema. Abbiamo avuto richieste dall’estero e adesso bisogna organizzare un piccolo tour europeo nelle sale. Non c’è fretta e il film non invecchierà tanto velocemente.
• C’è in The Perfect Circle una scena che ami particolarmente?
La mia scena preferita è quando Linda prepara Meris, sua mamma, per la cena e l’avvolge con lo scialle. Riconosco nei suoi gesti, tutto quello che mi manca DEL PRENDERMI CURA di mia madre, l’armonia dei nostri corpi e la sintonia delle nostre menti, favorita dalla sua afasia. Il nostro era un rapporto molto fisico, di risate, balli sul terrazzo, baci e carezze. Non credo avremmo mai avuto un tale rapporto senza quella orribile malattia. Eravamo due donne troppo indipendenti, più “del fare” che “dello stare”.
Quando arrivava il fine settimana, prendevo l’auto e andavo al paese dei miei genitori. Mentre scendevo dall’ultimo cavalcavia, sentivo un grande rilassamento allo stomaco, una serenità diffusa, il tempo rallentava e non avrei voluto essere da nessuna altra parte al mondo. In definitiva, credo che la mia esperienza mi abbia portata a conoscere sia il peggio che il meglio di me stessa. Mia madre ha imparato a farsi aiutare dagli altri, mio padre a crearsi un rapporto tutto suo con i figli e mio fratello ad avere la forza di lottare per la sua felicità anche quando il suo iperbolico senso della responsabilità lo faceva rinunciare a tutto.
• Che cosa ti hanno insegnato Meris e Ivano, i protagonisti?
Da Ivano ho imparato la rabbia “rispettosa”. Lui era arrabbiatissimo, ma stava sempre molto attento a non travolgere le persone. C’era sempre gentilezza anche nelle sue reazioni più scontrose. La rabbia è un sentimento per lo più cieco, che non si preoccupa di travolgere gli innocenti, di mancare di rispetto, anzi, spesso l’obiettivo è quello di ferire l’interlocutore per contagiarlo con una sofferenza simile alla nostra. Ivano stava molto attento a non infettare nessuno anche nell’affermare il proprio diritto di esprimere la propria rabbia. Mi ricordava una bella biografia che lessi sul Che, “Senza perdere la tenerezza”. Ivano sapeva esprimere tenerezza e gentilezza anche quando travolto dalla rabbia. Non mi era mai capitato prima di incontrare persone con una tale misura. Di Meris mi ha stupito l’umiltà con cui sapeva accettare l’aiuto di chi le stava attorno. Non è facile. Penso di me che farei come quei capi indiani che si isolano in un posto remoto per concludere la propria vita lontano da occhi indiscreti e in totale solitudine. Poi mi viene in mente Meris e credo che, al bisogno, anche io potrei sforzarmi di non escludere nessuno, perché la malattia non è mai solo un fatto privato, coinvolge le famiglie, le reti amicali. Non sono certa che sarei inclusiva come lei, ma potrei provarci, anche perché ho imparato da lei alcuni trucchetti per reclamare un po’ di solitudine senza ferire nessuno. Meris era davvero una donna che sapeva cosa voleva. L’ho ammirata moltissimo e invidiato la sua forza.
• Per te, cos’è oggi una “buona morte”?
Credo di augurarmi una fine in cui il mio principio di autonomia sia rispettato, senza sentirmi abbandonata, e in cui tutto ciò che è possibile fare in ambito clinico trovi un limite quando il beneficio terapeutico sia nullo, ma non conosca limiti dal punto di vista spirituale, sociale e psicologico. Credo che una “buona morte” sarebbe in un hospice immerso nelle colline. Lo dico sempre, scherzando, con i miei amici dell’hospice Casa Madonna dell’Uliveto. Lo dico scherzando, ma lo penso sul serio. Sapere che luoghi come quello esistono mi dà tranquillità e mi fa concentrare sulla mia vita, perché una buona morte dipende anche da quello, da come si è vissuto, da quanto si è vissuto. Il primo romanzo che lessi, a dieci anni, fu “Niente e così sia” della Fallaci. Il libro racconta un paio di anni in cui la giornalista visse molto pericolosamente tra rapimenti, colpi di stato, interviste con personaggi poco raccomandabili. Si apriva con la nipote che le faceva una domanda “Zia, cos’è la vita?”. Oriana, la zia, non sapeva bene che rispondere. Poi al rientro da quel viaggio, e alla fine del libro, si sente di poter dare una risposta alla nipote e dice qualcosa che suona più o meno così: “La vita è una cosa che va riempita tanto, il più possibile, ma si deve stare attenti, perché ad un certo punto si può rompere”. Forse una buona morte avviene dopo che si è vissuto talmente intensamente da non rammaricarsi se è il momento di andarsene. Senza dolore. Con la dignità intatta. Con gratitudine.
• Cosa ti aspetti dalla proposta di Legge sul fine vita? Cosa vorresti?
La Legge sulle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (DAT) ora al Senato, non ha ancora nessun articolo sul fine-vita, quindi, di fatto, è solo una legge sull’autodeterminazione. Ovviamente ha una ricaduta su come potremmo finire la nostra vita, ma non credo che l’accanimento clinico sia l’unico problema del fine-vita.
Io vorrei una legge sul fine-vita che affidasse alle cure palliative il fine-vita nella sua complessità e anche nei reparti ospedalieri. Vorrei che le cure palliative fossero un corso di studio nelle facoltà mediche, magari anche una Scuola di Specializzazione, vorrei che ci fossero più investimenti nelle reti domiciliari e meno soldi investiti in monumenti alle istituzioni della medicina e della politica. Il ruolo del medico di famiglia va ripensato. I medici generici sono l’anello di congiunzione con la cittadinanza e non è pensabile che non sappiano quanti pazienti in “fine-vita” hanno e di cosa abbiano bisogno le famiglie. È certamente un bene che ci sia una Legge sulle DAT, ma il lavoro da fare è tantissimo. Non possiamo continuare a rimandare una legge sul suicidio volontario assistito.
• Anche in questo senso le Cure Palliative possono dare delle risposte importantissime.
Nella quasi totalità dei casi in cui i pazienti entrano in un programma di cure palliative le richieste sono: 1. “Dottore non mi lasci solo” 2. “Quando non capirò più nulla, voglio che mi faccia morire”.Dopo aver iniziato il percorso con l’équipe palliativistica, la richiesta di morte volontaria assistita scompare quasi sempre. E perché? Perché nelle cure palliative, il rapporto stretto tra équipe, malato e famiglia crea un clima tale di fiducia e di condivisione delle scelte che il paziente si sente al sicuro, non ha paura di essere abbandonato, e sa di avere sempre “l’opportunità” della sedazione terminale e profonda quando i sintomi dolorosi non sono più trattabili.Sì, perché la sedazione profonda non provoca la morte, ma annulla la coscienza nell’attesa del cedimento delle funzioni biologiche.
Il discorso è diverso per i casi come quello di DJ Fabo, che non era malato terminale, ma viveva un’angoscia non più tollerabile per lui. Anche in questo caso, io sono favorevole al suicidio volontario assistito, purché non alla “maniera svizzera”… che vuol dire che il medico accerta le condizioni del richiedente ma è quest’ultimo a provvedere ad autosomministrarsi il farmaco letale.
• Non tutti riescono a morire in hospice o a casa, seguiti attraverso Cure Palliative…
Ci sono molte persone che non vengono riconosciute in condizione di “fine-vita” se non al momento del decesso. L’80% del fine-vita, nella nostra Regione, si conclude in ospedale, dove non si è affatto attrezzati per affrontarlo. A Baggiovara di Modena, però, hanno iniziato una sperimentazione con tre letti preposti al “fine-vita” nel reparto Geriatrico per i pazienti già ospedalizzati. Camere singole, supporto psicologico…Questo è un bel passo avanti.
• Per quanto riguarda invece il tuo caso personale?
Mia madre è stata male di domenica, dopo pranzo. Era già successo. La portavamo al Pronto Soccorso, da lì la portavano in reparto a Medicina e dopo dieci giorni tornava a casa, alla sua ridotta autonomia, ma mai allettata. Quell’ultima domenica, pensavamo che fosse una delle tante crisi. Quindi che si fa? Andiamo al Pronto Soccorso. Due ore di attesa su un lettino. Il medico di turno la visita e si arrabbia perché “Un paziente in queste condizioni non dovrebbe venire in Pronto Soccorso ma stare a casa”. Quali condizioni? Cosa era cambiato rispetto alle altre volte? “INR con valore 8”, mi dicono. Ne so quanto prima. Passano altre due ore in corridoio, poi due in una saletta e finalmente la mettono in un reparto. Mia madre inizia a fare quel rantolo terribile che non scorderò mai. Costringo le infermiere a sedarla anche se loro mi dicono che lei è già in coma epatico. Non mi interessa. Non voglio nemmeno lontanamente correre il rischio che lei soffra. Il suo ultimo giorno lo ha passato così, con un rantolo che io temevo disturbasse gli altri presenti e per cui la tenevo su un fianco e le massaggiavo la schiena perché non lo facesse. Immaginiamo, invece, che di domenica pomeriggio io avessi potuto chiamare il suo medico di base, quello che da mesi ci avesse seguito, e ci avesse spiegato il decorso della malattia. Lo stesso che ci avesse seguiti assieme al suo collega psicologo, all’infermiera e ai componenti del team palliativistico domiciliare. Ammettiamo che, arrivando entro un’ora, e accertando che ormai eravamo in dirittura d’arrivo, avesse subito attivato la vigilanza dell’infermiera e ci avesse preparati alla sua morte. Mia madre sarebbe rimasta a casa. Non avrebbe avuto lo stress del trasporto in ospedale, della visita, dell’attesa in corridoio. E la mia comunità avrebbe risparmiato i soldi di un inutile ricovero e di inutili esami.