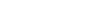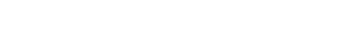Camelia Ciuban è nata nel 1970 a Timisoara, Romania. In Italia dal 1999 vive in provincia di Mantova. Laureata in Giornalismo e Scienze della Comunicazione ha pubblicato testi in vari volumi, collaborando con riviste e giornali in lingua italiana e rumena. L’abbiamo incontrata.
Camelia Ciuban è nata nel 1970 a Timisoara, Romania. In Italia dal 1999 vive in provincia di Mantova. Laureata in Giornalismo e Scienze della Comunicazione ha pubblicato testi in vari volumi, collaborando con riviste e giornali in lingua italiana e rumena. L’abbiamo incontrata.
1 • Nel tuo romanzo di esordio, È quasi tregua, hai affrontato argomenti importanti, quali dittatura, libertà, immigrazione, perdita, suicidio… Qual è il motivo per cui hai scelto di donare la tua storia ai lettori?
Può darsi che per qualcuno scrivere sia una scelta; per me non lo è. La scrittura, nel mio caso, è necessità, è urgenza, è un modo di vivere, un mezzo per capire, e capirmi. Poi ho sempre preferito la realtà alla finzione, i fatti veramente accaduti a quelli inventati; la realtà è sempre sorprendente e mi stupisce più di quanto riuscirebbe a farlo la fantasia più ingegnosa. Ciò che, ai tempi, mi aveva indotto a mandare in stampa “È quasi tregua” è stato il desiderio di offrire al lettore italiano un quadro più approfondito e dettagliato su una realtà con la quale, negli ultimi 25 anni, ci si confronta spesso: i rumeni in Italia. L’idea che si ha di noi in generale è estremamente schematica e fondata più che altro su pregiudizi. Spero che il mio primo libro possa agevolare una comprensione più realistica per chi volesse liberarsi di idee stereotipate e crearsi un pensiero più completo e obiettivo sull’argomento.
2 • Mentre nel tuo ultimo libro, La Belva, racconti una parte della tua vita vissuta sotto il dominio del disturbo bipolare. Non hai temuto di essere giudicata?
Quando un timore si tramuta in certezza non inquieta più, diventa solo un problema da risolvere o, in alternativa, un dato di fatto di cui farsene una ragione. Che tanti siano pronti a giudicare e a bollare è una certezza; che qualcuno dopo aver letto “La belva” mi guardi con un occhio più critico è altrettanto scontato. Ho capito che essere giudicata non dipende dalle mie azioni (esemplari o biasimevoli) ma solo da chi non ha nulla di meglio da fare. Quel genere di persone però, non fanno il mio interesse, di conseguenza non mi provocano né caldo né freddo. La malattia mentale è, ancora, per tanti (malati od osservanti), un argomento tabù nonostante sia una realtà più seria e diffusa di quello che si vuol accettare. Io ho deciso di parlarne apertamente perché a me, parlare, approfondire, capire, ha fatto bene. E no, non temo di essere giudicata nonostante sappia di esserlo.
3 • Come è stato frugare nel passato per raccontare di te?
Gran parte del libro è stato scritto nell’immediatezza degli eventi che racconta. Invece per alcuni brani ho dovuto dissotterrare i miei “scheletri dell’armadio”. È stato a volte sconvolgente, altre risanante, altre ancora sorprendente; sempre, senza eccezione, illuminante. La memoria è componente fondamentale della vita. Passato e presente si fondono dentro di me. Senza un solo frammento del mio passato sarei un’altra. L’oggi sarebbe diverso. Guardarsi dentro, a distanza di tempo, cercare di rispondere a dei “perché” che ai tempi sono rimasti in sospeso è un ottimo esercizio per potenziare le capacità di analisi obiettiva, è un mezzo efficace per conoscersi meglio. In più, penetrando e comprendendo bene il passato si è più facilitati a trovare risposte e soluzioni a domande che sorgono oggi.
4 • Ti sei mai vergognata della malattia?
No, della malattia mai. Mi vergogno tuttora di tutti quei momenti in cui ho permesso alla mia malattia di tradursi liberamente in manifestazioni che hanno arrecato dei pregiudizi sia alla mia dignità che alla sensibilità di chi, in quei momenti, mi stava vicino. Di questo non smetterò mai di vergognarmi e se mai dovessi farlo, lo credo con fermezza, non sarebbe per nulla producente.
5 • Tra le pieghe della mente sofferente cosa ti ha aiutato?
È una domanda talmente complessa che ho scritto un libro per cercare di rispondere. Comunque due elementi sono fondamentali: il primo è che nessuno ti può aiutare se prima non incominci ad aiutarti da solo. Il secondo è non smettere mai di cercare di capire: analizzare, indagare, approfondire, applicarsi e non sedersi mai in tribuna a guardare, come se il protagonista non fossi tu, lo spettacolo della tua vita.
6 • L’amore, tra i molti ingredienti, può indicare la via. Che valore ha avuto per te l’affetto ricevuto?
L’amore è fondamentale, ma è indispensabile a prescindere, se sei malato di mente o sano come un pesce. Essere amati, ma più che altro amare, è come avere un motore di riserva che si attiva qualora il motore principale vada giù di giri. Però, l’ho scritto anche nel libro, “l’amore non è tutto: da solo non vale niente. Sdolcinati sì, ma realistici! È, forse, paragonabile agli eccipienti dei medicinali: quella sostanza, priva di qualunque azione curativa ma che è indispensabile per facilitare la stabilità, la conservazione, la somministrazione e l’assorbimento dei principi attivi”. L’amore è un mezzo utile per arrivare, non è il traguardo.
7 • Potresti indicarci almeno altri tre fattori che ti hanno aiutato?
1. Studiare, informarmi e cercare di capire.
2. Non credere sempre ciecamente a tutto ciò che penso.
3. Rita Casarotti, l’unica psicoterapeuta che ha saputo mettermi in mano le redini della vita.
8 • Qual è stato il percorso che ti ha permesso di ammettere e capire di essere ammalata?
Sicuramente capirlo non è stato molto difficile, nel momento in cui ti ritrovi ricoverato in un ospedale psichiatrico, c’è poco da capire: i dubbi sul fatto di essere malato o meno (se c’erano) senz’altro si diradano. Ammetterlo invece è un lavoro più complesso. L’ammissione, non della malattia bensì di essere malato di mente, è un processo difficoltoso che suppone tanta introspezione, autoanalisi e umiltà. Non penso che il processo verso l’amissione sia uguale per tutti, ogni mezzo è valido purché ci si arrivi.
9 • Nel tuo caso?
Nel mio caso il fatto di incominciare a parlare liberamente del mio problema è stato fondamentale. Però, l’ammissione della malattia, per quanto possa sembrare il punto centrale, è solamente un passo importante da compiere che, se non ti porta ad altro, ti può mettere su una specie di binario morto da dove difficilmente riesci a spostarti. Nel momento in cui avevo capito che i miei disturbi avevano un nome rintracciabile nel dizionario medico, ciò divenne una sorta di scusante, ero quasi giustificata ad essere com’ero. I miei comportamenti non erano capricci che avrei potuto evitare con uno schiocco di dita e nemmeno stranezze di origine incerta, non ero una brutta persona, labile e incoerente che permetteva ai propri limiti di tradursi in atti disdicevoli senza combattere ma ero malata. Era come se, di colpo, mi fossi guadagnata il diritto di essere com’ero. La tendenza di accogliere la malattia quasi come un dono, come un dato immutabile, è estremamente pericolosa perché non permette l’apertura mentale necessaria per ipotizzare un intervento serio dall’interno. Bisogna capire che qualsiasi problema può essere combattuto e se la malattia ti appartiene (perché c’è nel tuo sangue), invece le manifestazioni comportamentali di essa, con tanto sforzo ed esercizio, possono essere arginate.
10 • Ciascuno nella vita deve affrontare momenti difficili o problemi seri ma sono pochi coloro che – a causa di tali circostanze – decidono di sottrarsi alla vita, mentre nel disturbo bipolare il rischio di suicidio è trenta volte superiore a quello della popolazione generale. Pensi che la depressione sia ancora sottovalutata?
La depressione è decisamente sottovalutata. Da tanti viene considerata come una specie di malattia di grado inferiore, una sorta di pseudo-patologia dovuta più che altro ad un carattere debole che a processi biochimici che sconvolgono la mente. Tamara era la mia amica. Una ragazza sorridente e generosa. Si è uccisa pochi mesi fa, a soli ventisette anni, durante il primo crollo depressivo della sua vita. Siccome lavoravamo nella stessa azienda, ho potuto osservare come la sua malattia veniva percepita dalla maggior parte delle persone nell’ambito: il problema non era il fatto che una giovane donna era stata colpita dalla depressione bensì la sua latitanza dal lavoro. Stava a casa perché non aveva voglia di lavorare, se ne approfittava della possibilità di rinviare il suo rientro al lavoro e si dubitava fortemente della sua voglia di riprendere l’attività. Tutto questo intanto che aveva cambiato tre o quattro psichiatri perché i trattamenti che le erano stati prescritti non le davano alcun giovamento. È morta così, con addosso l’etichetta di svogliata e inaffidabile, tra un farmaco inutile (o addirittura controproducente) e psichiatri dozzinali.
11 • Di fronte alla mente umana si va per tentativi e non sempre si incontra il dottore giusto. Cosa ne pensi della psicoterapia?
Penso che la psicoterapia sia un mezzo potente e fondamentale a patto che sia fatta da persone veramente competenti. E qui per competenza non intendo la licenza in psicoterapia (questa la può prendere chiunque abbia voglia di studiare) bensì reali abilità, capacità e dedizione. Non è un mestiere qualsiasi che si può apprendere con un po’ di formazione specifica: è un lavoro di immensa responsabilità. Purtroppo, l’idea generale che si è creata è quella che la psicoterapia si riduca a lunghe chiacchiere a dei costi esorbitanti; e se si pensa questo, qualche fondo di verità ci sarà. Credo che ciò che sprona tanti psicoterapeuti a fare questo lavoro, non sia tanto la passione e l’interesse quanto l’idea di intraprendere un’attività veramente remunerativa.
12 • Quali sono oggi i progetti di Camelia Ciuban?
Nel libro ho scritto ad un certo punto che negli ultimi anni ho fatto sette traslochi. Ebbene il libro è datato: ho appena fatto l’ottavo e per ora sono solo estremamente impegnata a rendere la nuova casa un posto da vivere. Oltre a questo che è un progetto in atto, non ne ho altri. È la vita stessa che, portandomi delle novità, fa nascere i miei progetti. Diciamo che Il Progetto è quello di accoglierli tutti, mano a mano che arrivano. Dal punto di vista del disturbo bipolare, so di essere ormai sulla buona strada e l’intenzione è quella di restarne fedele.